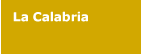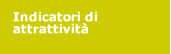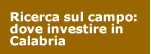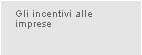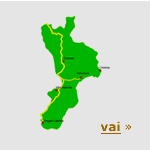| |
Dopo Coleman, il concetto di capitale sociale è stato spesso utilizzato
come fat¬tore esplicativo dello sviluppo. Le riflessioni che più
hanno influenzato il dibat¬tito su questo tema sono state quelle operate
da Putnam e da Fukuyama , che hanno dedicato maggiore attenzione al legame
fra capitale sociale e sviluppo e hanno sottolineato le dimensioni valoriali
e culturali derivanti dalla storia dei sistemi sociali.
Putnam ha spiegato le differenze nel rendimento istituzionale delle regioni
italiane a partire dalla loro dotazione di capitale sociale. In Putnam,
però, que¬st'ultimo termine assume un valore particolare: designa,
infatti, le caratteristiche dell' organizzazione sociale, cioè il
tessuto di norme e valori che la permeano e le reti di associazionismo che
la compongono, le quali promuovono l'azione col¬lettiva e la cooperazione.
li capitale sociale è, insomma, l'insieme dei valori pre¬senti
in un dato contesto sociale, quali la fiducia, la tolleranza, la solidarietà,
ele¬menti che formano la cosiddetta civicness.
Queste relazioni di solidarietà e cooperazione, in quanto producano
capitale sociale, devono estendersi al di là delle reti familiari
e parentali. In questo senso, il concetto di cultura civica appare specularmente
contrappo¬sto a quello di "familismo amorale" reso famoso
da Banfield negli anni Cinquanta. Va sottolineato che per Banfield, il familismo
si basa sul principio di massimizzare i vantaggi a breve termine del nucleo
familiare. La presenza della cultura del familismo è quindi ritenuta
la causa della mancata mobili¬tazione del Mezzogiorno d'Italia per affrontare
la sua arretratezza economica.
Putnam sostiene anche che i differenti rendimenti istituzionali e i diversi
livelli di svi¬luppo economico delle regioni del Sud rispetto a quelle
del Nord dipendono dalla minore presenza di capitale sociale e dalla sua
natura. Non tutte le reti di relazioni sono, infatti, favorevoli allo sviluppo.
Solo le reti sociali orizzontali, che legano individui dotati di medesimo
status e medesimo potere, favoriscono la fiducia e la cooperazione. Le reti
verticali, caratterizzate da relazioni asimme¬triche, non producono
invece gli stessi effetti sociali.
|
|
È, inoltre, necessario che le
relazioni di fiducia e cooperazione si estendano dalla cerchia parentale
a retico¬li sociali orizzontali più complessi, diffondendo così
norme di reciprocità gene¬ralizzata.
L'origine di tali reticoli e di tali norme viene da Putnam ricercata nella
lunga durata storica. L'assenza dalla civicness troverebbe le sue origini
nella diversa storia del Mezzogiorno rispetto al Nord a cominciare dal XII
secolo, quando, mentre al Nord si costituivano i liberi Comuni, nel Sud
si affermava la monarchia normanna, certo progredita dal punto di vista
economico e culturale, ma carat¬terizzata da una struttura sociopolitica
feudale tendenzialmente burocratica e assolutista.
Da allora nella penisola italiana si sono formati due sistemi sociali differenti,
che sarebbero evoluti secondo logiche contrapposte, cristallizzandosi in
culture e istituzioni di tipo orizzontale al Nord e verticale al Sud.
Ad esempio, nello studiare le ragioni del successo dei distretti industriali
italiani del Centro e del Nord-Est, è riduttivo pensare che esso
possa essere spie¬gato unicamente dalla pur notevole presenza di capitale
sociale . E’, invece, necessario considerare i fattori macroeconomici
che lo hanno facilita¬to (non è un caso che i distretti si affermino
alla fine del grande periodo di espansione economica italiana del dopoguerra)
e la presenza consistente di capitale sia umano e sia finanziario.
Altrettanto importante è considerare che la fiducia e il capitale
sociale posso¬no prodursi ex novo quando si verifichino nuove tipologie
di relazioni sociali o, al contrario, possono consumarsi quando siano usati
in chiave esclusivamente stru¬mentale (così come, secondo Weber
, i beni esteriori si trasformano in una gabbia che finisce per far sparire
la radice dell' etica puritana da cui era nato il capitalismo).
|
|
Le stesse ricerche empiriche sulla relazione tra
fiducia, capitale sociale e crescita economica ci spingono ad adoperare
modelli causali più complessi della semplice relazione unidirezionale
tra fiducia/capitale sociale e sviluppo. A tal proposito, uno studio della
Banca Mondiale propone un quadro di riferimento concettuale per interpretare
lo sviluppo in cui il rapporto tra fattori socio culturali e crescita economica
è mediato dalle modalità di fun¬zionamento delle istituzioni
politiche. Innanzitutto, viene adoperato il concet¬to di coesione sociale
al posto di quello più ambiguo di capitale sociale.
Le dimensioni principali della coesione sono: i tassi di partecipazione
associativa, la fiducia negli altri componenti della società, la
distribuzione del reddito fra le diverse classi, l'eterogeneità etnica
e linguistica. Naturalmente ciascuna di que¬ste grandezze è correlata
positivamente con i tassi di crescita economica, anche se in misura diversa.
Le ultime due: la distribuzione del reddito e l’eterogeneità
etnica e linguistica correlano in misura maggiore, mentre molto debole appare
la correlazione della prima: i tassi di partecipazione associativa, che
è forse la più classica unità di misura del capitale
sociale. Ma è soprattutto interessante notare come il rappor¬to
fra coesione sociale e sviluppo sia mediato da un'altra variabile fondamenta¬le
che è la qualità delle istituzioni politiche.
La coesione sociale, cioè, è la condi¬zione ambientale
che consente la costruzione di istituzioni più solide, più
demo¬cratiche e più orientate al bene comune, non condizionate
della difesa di inte¬ressi particolaristici. È la performance
di queste istituzioni che poi spiega più direttamente lo sviluppo
economico di un paese. |